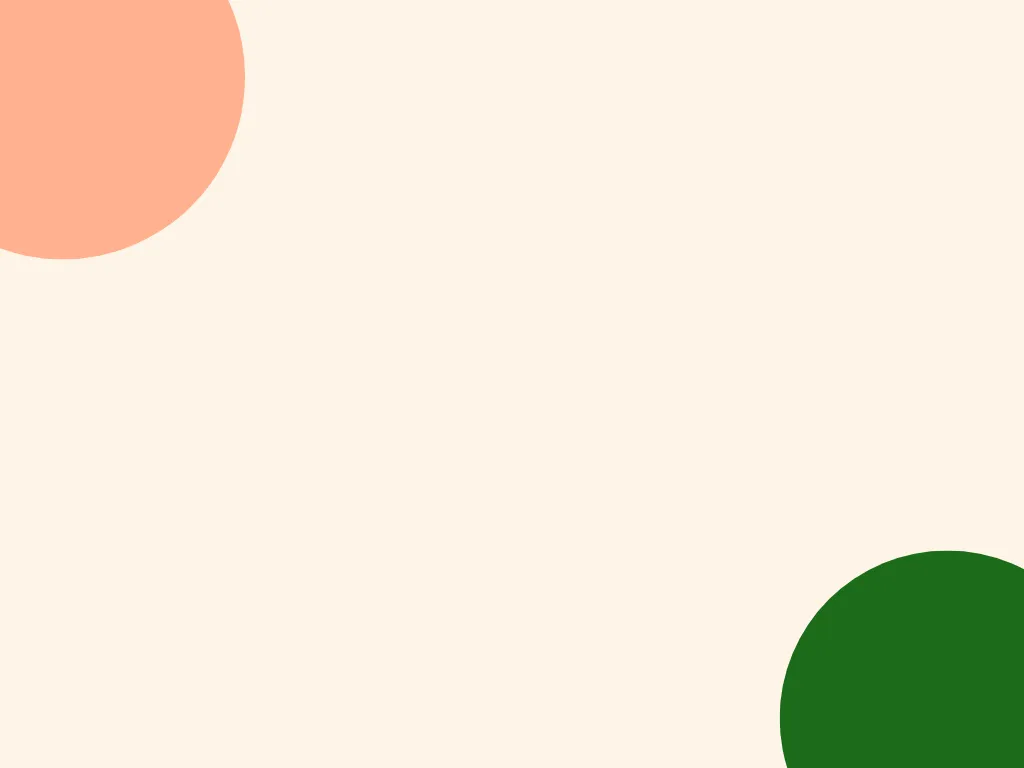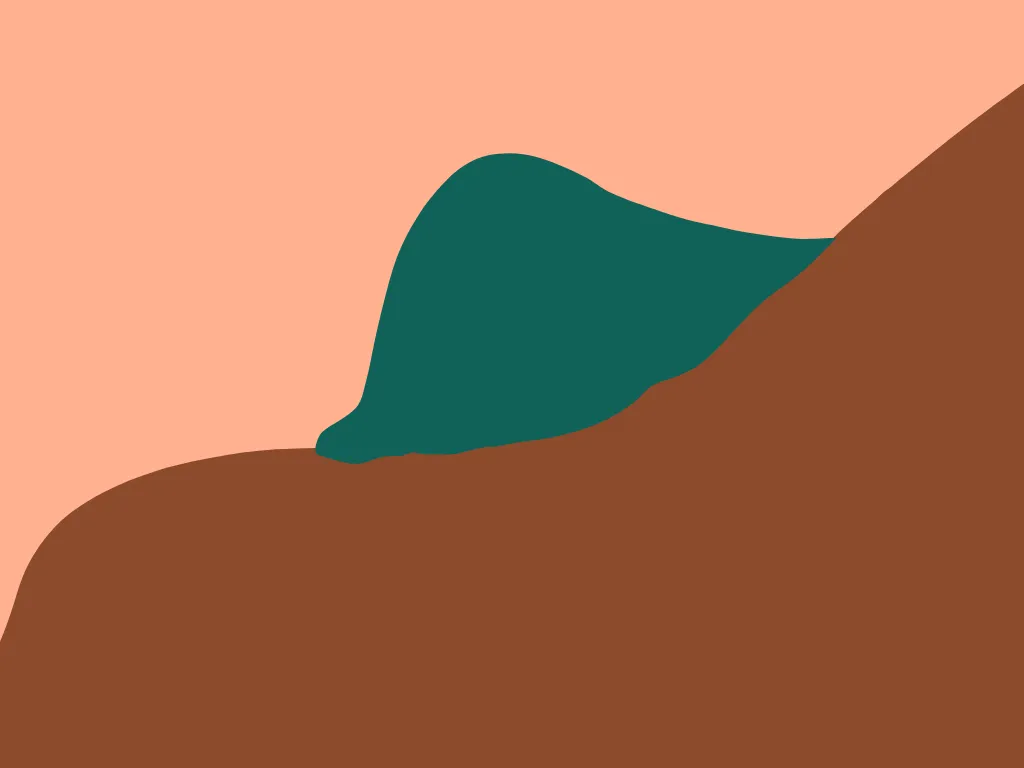Accettazione o rinuncia all'eredità: cosa sapere per decidere consapevolmente
Quando si riceve una comunicazione di apertura di successione, il primo pensiero spesso va al patrimonio ereditato. Ma l'eredità non è fatta solo di beni: può includere anche debiti, obblighi e situazioni patrimoniali complesse. È per questo che la legge italiana offre la possibilità di accettare o rinunciare all'eredità, entro tempi e modalità ben precisi.
Conoscere i diritti e i doveri di chi eredita è fondamentale per evitare scelte affrettate o rischi legali. In questo articolo vediamo in dettaglio cosa comportano le due opzioni, come esercitarle correttamente e quali sono le implicazioni fiscali e patrimoniali.
Accettazione dell'eredità: espressa o tacita
Ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice Civile, l'accettazione dell'eredità può avvenire in due forme: espressa o tacita.
L'accettazione espressa si fa con un atto formale (generalmente redatto da un notaio o presso la cancelleria del tribunale), in cui si dichiara la volontà di accettare l'eredità. L'accettazione tacita, invece, si verifica quando l'erede compie atti che presuppongono la volontà di accettare, come vendere un bene ereditario, pagarne le tasse o prenderne possesso.
È importante sapere che l'accettazione ha effetto retroattivo: una volta avvenuta, non può essere revocata, e l'erede diventa responsabile anche dei debiti del defunto, salvo che non si sia optato per il beneficio di inventario.
Accettazione con beneficio di inventario
Per proteggersi dai debiti eventualmente presenti nell’eredità, la legge prevede la possibilità di accettare con il beneficio di inventario (art. 484 c.c.).
Con questa forma di accettazione, l’erede non risponde dei debiti del defunto con il proprio patrimonio personale, ma solo entro il valore dell’eredità ricevuta. È una forma prudente e consigliata soprattutto quando non si ha chiarezza sulla situazione patrimoniale del defunto.
L’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria per i minori, gli interdetti, gli inabilitati e gli enti pubblici. Va fatta con atto pubblico, entro 3 mesi dal decesso o dalla conoscenza dell’eredità.
Rinuncia all'eredità: quando e come si fa
La rinuncia all'eredità è prevista dall'art. 519 c.c. e consente a chi ha titolo di erede di rifiutare formalmente la successione. Può essere effettuata solo davanti a un notaio o presso la cancelleria del tribunale del luogo di apertura della successione, e deve essere registrata.
La rinuncia è spesso consigliata nei seguenti casi:
- Quando i debiti del defunto superano i beni;
- Quando ci sono contenziosi aperti o situazioni patrimoniali complesse;
- Quando si vuole evitare la responsabilità civile e fiscale connessa all’eredità.
Rinunciare significa rinunciare anche ai diritti successori futuri su quei beni. Tuttavia, se l’erede ha già compiuto atti che implicano accettazione (es. usare beni ereditati, pagare debiti), la rinuncia non sarà più valida.
Tempi e scadenze da rispettare
La legge non impone un termine rigido per accettare o rinunciare all'eredità. Tuttavia, se l'erede è nel possesso dei beni (ad esempio vive nella casa del defunto), deve accettare o rinunciare entro 3 mesi dal decesso, pena la presunzione legale di accettazione pura e semplice.
Se non si è nel possesso dei beni, il termine si estende a 10 anni. Tuttavia, è sempre meglio non attendere troppo, anche per evitare conflitti con altri eredi o l’accumulo di obblighi fiscali (es. imposta di successione, IMU, TARI).
Successione e responsabilità per i debiti
Accettare un’eredità in modo puro e semplice significa subentrare in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi del defunto. Questo include mutui, prestiti, cartelle esattoriali e qualsiasi debito non estinto in vita.
Solo l’accettazione con beneficio di inventario consente di limitare la responsabilità. Per questo motivo, prima di accettare, è sempre raccomandabile fare una verifica approfondita della situazione patrimoniale e, se necessario, rivolgersi a un professionista.